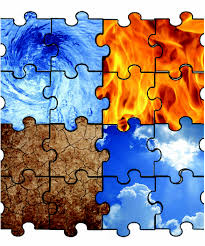
di Pietro Saitta, sociologo – Un paginone (p. 22), pubblicato il due settembre 2015 sul principale quotidiano messinese e firmato quasi per intero dal direttore stesso, informava la cittadinanza dello Stretto che il «decoro urbano è il primo vero bene comune» e anche che i militanti attivatisi con un presidio a difesa di una senza casa minacciata da un consigliere comunale di essere sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio, avevano dato luogo a un’azione che «non era giustificata da alcuna motivazione ‘ideale’. Niente che assomigliasse, seppure alla lontana, a iniziative tipo ‘Occupy Wall Street’, ma solo la difesa al bivacco».
Tuttavia essendo la «Gazzetta del Sud» più simile al «New York Post» che al «New York Times» – essendo cioè un foglio conservatore, popolare nel senso meno nobile del termine (si veda a tal riguardo Gramsci), caratterizzato frequentemente da analisi assai riduzioniste e quasi naturalmente chiuso, salvo aperture tattiche, ai processi sociali autonomi che intaccano la sostanza delle relazioni politiche – possiamo seriamente dubitare che, posto dinanzi a «Occupy», le parole impiegate dal direttore sarebbero state molte diverse. Anche questo movimento, infatti, sarebbe stato probabilmente degradato al ruolo di bivacco, di avamposto di una «guerra» dichiarata dagli anarchici, con la «copertura» di esponenti politici e intellettuali le cui parole «sembrano evocare drammi e tragedie» (anche se il lettore viene altresì avvertito che, in realtà, «qui è tutto una farsa…»).
Apprendiamo altresì che il sommovimento degli «antagonisti» (un’etichetta assai amata da questo giornale così sensibile ai cambiamenti del linguaggio) mostri «come inventarsi un caso dal nulla» e «come spacciarsi per eroi della libertà e dei diritti civili». Apprendiamo inoltre che il «decoro urbano […] è il primo vero bene comune di una città». Un «bene comune» é qualcosa, dunque, «che appartiene a tutti e chi si appropria di un pezzo non è altro che un ‘ladro’ […] che sia lo speculatore edilizio che ha assaltato le colline, l’imbrattatore di monumenti, l’abusivo che reclama solo diritti e mai doveri […] Ma chi ha a cuore le sorti di Messina non può sopportare l’assuefazione al degrado, alle dilaganti brutture e soprattutto al fatto che le regole sono l’obbligo per qualcuno e un optional per altri».
Se questa sintesi e selezione, da parte mia tutt’altro che malevola, di estratti dal testo apparso sull’influente quotidiano messinese, mette a nudo la cornice ideologica dell’analisi e la ridotta comprensione dei temi in discussione, essa serve anche come pretesto utile a ricondurre la riflessione sui fatti di questi giorni in una prospettiva più corretta, tanto dal punto di vista dei concetti che delle pratiche politiche.
Non ne avrà a male l’estensore del paginone se dico che le sue parole in materia di «beni comuni» riecheggiano in qualche modo quelle di una studentessa negli anni del mio «assistentato» presso la Facoltà di Sociologia di Urbino. Interrogata sul significato dell’espressione «banalità del male», la ragazza rispose più o meno che quelle parole indicavano «l’occorrenza per cui tutti possono fare del male, ma solo pochi del bene». Si arrampicava sugli specchi, insomma. Proprio come fa l’autore del summenzionato articolo, il quale ignora che l’espressione «bene comune», così come si è imposto nella letteratura scientifica, economica, giuridica e sociologica internazionale a partire dal pionieristico articolo di Hardin e poi dei fortunati libri di Ostrom e Mattei, ha ben poco a che fare con l’impiego che egli ne fa.
Il concetto di «bene comune», se impiegato seriamente e genealogicamente, e non come espressione da sfoggiare o impiegare tatticamente per fini politici contingenti e triviali, appare infatti connesso primariamente al bios, cioè alla vita, e non certamente al problema di vietare l’occupazione di aiuole o marciapiedi per fini abitativi. In estrema sintesi, i beni comuni sono esattamente quelle risorse indispensabili alla riproduzione della vita che, a seconda delle prospettive e delle circostanze, possono essere gestiti autonomamente dalle collettività oppure in maniera centralizzata e istituzionalizzata. Col tempo il concetto ha finito con l’includere beni e artefatti materiali, operando così una sintesi tra istanze materialiste e postmaterialiste e finendo con l’includere edifici, immobili e altri simili beni, che, pur non risultando funzionali al soddisfacimento di bisogni strettamente biologici, sono comunque connessi alla «buona vita». Si tratta di trasformazioni concettuali e processi di inclusione di nuovi ambiti di conduzione della vita individuale e associata, che riecheggiano parzialmente quelli consolidatisi in altri settori del diritto (si pensi per esempio alla nozione di «danno esistenziale», o ai «diritti di nuova generazione» come quello all’ambiente e altri ancora).
Ciò che differenzia il dibattito sui beni comuni da altri apparentemente non troppo distanti da esso, è il suo carattere «protettivó» della collettività e se così possiamo dire, «anti-liberista». Se non è del tutto corretto dire che il dibattito sul «bene comune» è la difesa del «pubblico» (infatti anche soggetti non istituzionali possono prendersi cura dei beni), esso è comunque qualcosa che sottintende un’etica fondata sulla salvaguardia delle risorse di utilità collettiva e sulla loro gestione, per fini che sono legati alla difesa della vita (collettiva oltre che, naturalmente, individuale).
Se questa sintesi è oltre modo riduttiva, quel che preme sottolineare qui è che nel parlare di «beni comuni» ci troviamo in ambiti molto più elevati di quanto immaginato dal commentatore sopra menzionato. E anche affermare che, se ci ostiniamo a usare la categoria di bene comune proposta dalla stessa «Gazzetta del Sud», la vicenda ci pone dinanzi a un interessante paradosso: quello per cui l’impiego di una risorsa pubblica – aiuola o marciapiede che sia – per sopperire a un bisogno fondamentale come l’alloggio (e dunque per tutelare il bios), in un quadro in cui i beni necessari al suo soddisfacimento siano relativamente e oggettivamente scarsi in ragione di elementi legati alla proprietà immobiliare, all’indisponibilità o insufficienza di quelli pubblici e persino in ragione dell’indisponibilità dei soggetti destinatari a impiegare gli alloggi caritatevoli presenti per ragioni legate a stringenti motivazioni personali, si configura come una opzione plausibile e lecita – una fattispecie, potremmo dire a fini comparativi meramente esplicativi e comunque caratterizzati da alcuni limiti di applicabilità, non troppo diversa da quella che, già nel nostro ordinamento attuale, consente a soggetti gravati da necessità di alienare momentaneamente la proprietà privata altrui (sulle distinzioni, le occorrenze in materia per esempio di furto d’uso, si veda: Cass. 16012/2005).
In termini più diretti, con buona pace dell’opinionista del quotidiano e dei consiglieri che hanno avviato questa campagna morale culminata in due arresti, dormire è un bisogno fisiologico che chi è senza casa, deprivato momentaneamente o definitivamente di relazioni sociali e convinto oppure necessitato a non sottoporsi ai regolamenti e agli orari degli istituti di assistenza, non può che assolvere in strada. Un bisogno che, a differenza di altri (per esempio, defecare o urinare in strada) non rischia di pregiudicare la salute pubblica, né offende la morale pubblica. Se lo facesse, difatti, esisterebbero regolamenti che impedirebbero ai pendolari di addormentarsi su treni e metropolitane e agli estranei di condividere gli scompartimenti notturni degli stessi treni o degli ostelli.
Cos’è dunque che fa sì che un giornalista, un «intellettuale intermedio», così come dei politici, possano sostenere con tale faciloneria che una tenda sia un problema? Evidentemente, e parzialmente, alla base vi sta l’idea, divenuta popolare a un certo punto della storia moderna e contemporanea, che la città debba essere il luogo della conformità a un modello estetico ed etico. È cioè la prevalenza di quella che autori come Jeff Ferrell, Randall Amster e Margaret Kohn (si vedano, rispettivamente, i loro Crimes of Style, Street People e Brave New Neighborhood) hanno chiamato, con parole pressoché identiche, «estetica dell’autorità e del potere». È l’idea, cioè, che la città debba essere, se non lo spazio della bellezza, quello della regolarità.
Il luogo, in altri termini, dove la popolazione si sottomette a comportamenti e pratiche prevalenti. È l’idea di una città dove gli uomini portano i capelli corti, le donne la gonna e ove, ordinatamente, si transita dallo spazio domestico a quello della produzione. È insomma l’idea della città che rifletta, a partire dalla sua estetica, l’ordine sociale, con le sue differenze di classe, di status e di prestigio.
È questa un’idea che balena nella mente delle élite sin dai tempi della Rivoluzione industriale. Più o meno tutti ricordiamo infatti lo stato della città – Londra, in particolare – nel momento del passaggio da un’economia rurale, che ha ovviamente luogo nella campagna, a quella della produzione di massa, che si svolge in ambiente urbano. La gran parte di noi ricorderà le immagini, giunteci attraverso le pagine di Dickens, di bambini che schiamazzano, di madri derelitte con poppanti in seno, di mendicanti, di borsaioli e ladri piccoli e grandi. Possiamo considerare quello il «punto zero» della questione urbana contemporanea. La stagione che darà inizio alla prigione, ai riformatori, alle case di lavoro e alle campagne morali come quelle intrattenute oggi dalla «Gazzetta del Sud». Ma anche alle case popolari, ai sussidi e al welfare.
Se da allora è passato molto tempo e se la città è gradualmente diventata nel frattempo il luogo della diversità, delle segregazioni dorate per i ricchi e dei ghetti per i poveri, dell’anomia, dell’anonimato, della creatività e di quella che possiamo definire il pluralismo delle culture individuali e collettive, è pur vero che periodicamente delle spinte regressive tornano a farsi sentire.
Dagli anni ottanta a questa parte, il nome di questa spinta regressiva è: «neo-liberismo». Una filosofia economica e un insieme di pratiche di governance che si fondano su una visione «etica», per la quale il libero mercato non è naturale come ritenevano gli economisti classici, ma che vada costruito attraverso l’azione dello Stato. Uno Stato che da un lato è invitato a ritrarsi, tagliando la spesa pubblica, l’istruzione o la sanità, a favore della competizione tra strutture fornitrici di servizi e, dall’altro, chiamato a fornire le condizioni affinché questa «libertà» d’impresa possa compiersi.
L’etica di cui parlavo poco sopra è in questo senso la produzione di un tipo umano. Un tipo umano vecchio quanto la città capitalista stessa. È il soggetto produttore, per quanto precarizzato. È il soggetto senza troppi grilli per la testa, che non dia l’impressione di potere mettere a rischio gli altri, producendo così quella percezione di «insicurezza» che minaccia gli affari. È il soggetto consumatore, che deve affollare gli spazi commerciali egemoni nella struttura economica contemporanea (le grandi catene, una certa tipologia di bar etc.). È, inoltre, il soggetto che deve preferibilmente ritrarsi dalla partecipazione politica o, quantomeno, praticarla dentro spazi deputati e, soprattutto, lontano dalla strada. È, meglio ancora, il soggetto che deve fare politica delegando. Oppure autolimitando l’espressione delle proprie idee al mondo virtuale, abbaiando lì, senza però aggregarsi e producendo effetti visibili e «disordinatori» sulla città.
Ma se la città deve riflettere il potere a partire dall’estetica, è la categoria di «decoro», così ovvia per gli opinionisti della «Gazzetta del Sud», che dev’essere analizzata. Come notava Tamar Pitch in un suo interessante volumetto divulgativo (Contro il decoro. L’uso politico della pubblica decenza, uscito per i tipi di Laterza), la cui lettura è altamente consigliata a tutti quegli operatori dell’informazione e ai cittadini che si affannano a usare questa espressione, inaudibile e impronunciabile per storia e implicazioni:
«’il decoro è il complesso di valori e atteggiamenti ritenuti confacenti a una vita dignitosa, riservata e corretta’, ma anche ‘dignità che si manifesta nell’aspetto e nel contegno’. È sinonimo, appunto, ‘di dignità, contegno, convenienza, discrezione’… Ma se i ricchi possono essere ‘discreti’, forse ‘dignitosi’, ben difficilmente saranno definiti ‘decorosi’ […] Ma resta il fatto che nel senso comune prevalente il sostantivo ‘decoro’ e l’aggettivo ‘decoroso’ non si applicano a tutte le posizioni sociali. Come a dire che i ricchi e i potenti non hanno bisogno di imporsi i limiti e non devono essere ‘decorosi’ (Pitch, 2013, pp. 8-9).
E se guardiamo alla storia recente di questo vocabolo – quella che possiamo ricordare più facilmente per averla testimoniata nel corso del nostro passaggio sulla Terra – vi sono pochi dubbi che «decoro» è quel sostantivo divenuto popolare da quando, per mano di abili «imprenditori morali», è emersa la nuova questione sociale rappresentata da immigrati, prostitute, «abitatori della notte» (il popolo delle discoteche, degli aperitivi, dei centri sociali etc.), che hanno proiettato la nostra società verso nuovi stili di vita e consumi e verso quella che possiamo chiamare la nuova «grande trasformazione»: quella neoliberista. Per l’appunto una nuova età di transizione, che, come negli anni della Rivoluzione industriale, richiede una nuova ondata disciplinare ed etica.
E poi, naturalmente, l’interesse. Quello, per intenderci, che oscilla tra la spinta irredentista a liberarsi del «sindaco scalzo» e quella che mira invece a costringerlo a una «pacificazione» (addirittura superiore a quella che, purtroppo, egli stesso ha già da tempo intrapreso, alienandosi così le simpatie di molta della sua base) con le forze e i poteri temporaneamente «di minoranza». È il problema che ho chiamato in precedenza «della verità»: quella per cui da molto tempo il Sindaco Accorinti non ha più rapporti col Pinelli ed è anzi in un rapporto di ostilità con esso. Ragione per cui chiamarlo a responsabilità che non siano legate ad altro che alla questione dei servizi sociali e dell’assistenza, è un atto di pura speculazione politica e una bugia.
In conclusione, sottraendo al geografo sociale Neil Smith una sua fortunata espressione, malgrado quanto dichiarato dalla «Gazzetta del Sud» e dai consiglieri comunali che hanno lanciato questa folle campagna contro una donna senza casa, questa vicenda non ha a nulla a che fare con i diritti, i beni comuni o la legalità. Essa è semplicemente un paragrafo nella storia della città revanchista e disciplinare, che sogna un mondo conforme agli interessi di chi detiene gli interessi e il capitale necessario a trasformarla secondo i propri bisogni. È cioè solo un tentativo di normare e ordinare la vita dei cittadini, a discapito dell’universalità e dell’inclusione generalizzata.
E in conclusione, ancora una volta, mi tocca purtroppo ringraziare Irene e Sergio, i militanti che con i propri corpi hanno ostacolato quest’autentico attacco all’universalità e per questo si ritrovano oggi limitati nelle proprie libertà. Vorrei dire loro grazie per il coraggio e l’esempio dato. Lieto di dirmi vostro amico, compagno, complice.








